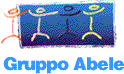 |
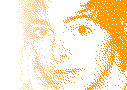 |
Annuario Sociale '99 |
|||
• Università della Strada • Ufficio Scuola • Edizioni Gruppo Abele • Narcomafie • Aspe • Animazione Sociale • Centro di Documentazione e Ricerca sulla Legalità • Università Internazionale della Strada • Ufficio Comunicazione • Annuario Sociale '99 |
Prefazione L'informazione e la speranza Tre anni di lavoro attorno al dispiegarsi dei fatti e all'interpretazione dei dati, in cui si è cercato di descrivere le "questioni sociali" (da intendere complessivamente come questioni culturali, politiche, educative, etiche) non più con la staticità di fotografie, che fissano il dettaglio e l'istante, ma con lo scorrere di immagini in movimento, che svelano tracce, sviluppi o regressioni dei problemi e dei modi e degli strumenti che si mettono in campo per affrontarli. Il sociale non avrà mai l'apparenza fredda delle ricerche matematiche o la ferrea evidenza dei risultati scientifici che si presentano, almeno fino alla dimostrazione successiva, inattaccabili. Il sociale è terreno di dispute non accademiche, di sofferenze reali, di angosce vissute, di speranze di futuro che si intrecciano con descrizioni e cifre, piegandole a letture che vestono le lenti delle diverse concezioni del mondo. Le idealità e le passioni sono le luci abbaglianti e le ombre minacciose senza le quali sarebbe difficile vivere; ma se la loro presenza si fa dominante diventa arduo porsi le domande necessarie, affrontare i dubbi salutari, andare a fondo di quel desiderio di capire che segna la vita e il cammino degli uomini. Dunque, ragionare si può e si deve, anche (anzi: ancora di più) di fronte a tensioni forti e a conflitti che appaiono a prima vista superabili solo con la rimozione, il rifiuto o la negazione dell'altro. Con l'Annuario sociale, che pure sta diventando uno strumento sempre più vasto e accurato, non abbiamo la presunzione e la volontà di dare risposte o fornire soluzioni, ma desideriamo mettere a disposizione di chiunque lo voglia una piccola e limitata risorsa per la navigazione; perché, se è vero che la rotta non è e non può essere lineare, è anche vero che le nebbie si possono fendere e, a volte, persino diradare. "Ascoltando" quotidianamente quel movimento e guardando ai fatti dello scorso anno, ci pare di capire che vi sono questioni sociali che vanno verso una pur lenta soluzione, aprendo nuovi scenari; altre che non riescono ancora a trovare il bandolo della matassa, rischiando la cronicizzazione; altre ancora che sembrano sparire dalle agende politiche, dopo essere state assai trascurate nella "gerarchia delle notizie"; altre, infine, che assumono ogni giorno nuovi e drammatici aspetti, che vanno governati lontano dalle tentazioni di facili interventi chirurgici: per problemi complessi non esistono soluzioni semplici. Se questa "classificazione" ha una validità, la lettura "in movimento" cui ci siamo dedicati e di cui questo volume è un prodotto, ci permette di inserire tra le prime questioni l'AIDS. La sua aggressività appariva fino a tre anni fa inarrestabile. Ora, stiamo bene attenti a non cantare vittoria: molti pensano erroneamente che la malattia sia debellata, e questo favorisce il diffondersi di nuovi contagi; i nuovi farmaci sono disponibili solo nei Paesi ricchi, per cui si sottovaluta l'estensione dell'infezione nei Paesi poveri e in quelle aree in cui la conquista della libertà non è stata finora in grado di garantire l'affrancamento dalla miseria per tutti. Ma è anche vero che gli sforzi della scienza e l'impegno del sociale cominciano a permettere tempi e qualità di vita diversi per le persone malate o colpite dal virus rispetto a un recente passato. Ciò non deve portare né al rallentamento della ricerca né all'abbandono delle iniziative per giungere a un maggior rispetto dei diritti individuali e di gruppo: molto rimane da fare, per migliorare le cure e per garantire condizioni dignitose di lavoro, reddito e libertà, ma si parte da un indubbio passo in avanti. Tra le seconde questioni, quelle a rischio di "cronicizzazione", troviamo l'eccessiva timidezza e la sostanziale immobilità rispetto a droga e carcere, due mondi fortemente e, in molti casi, forzatamente correlati. Ciò che manca in Italia a questo proposito non è il dibattito, che spesso assume la caratteristica negativa (e improduttiva) di un andamento "a singhiozzo", tra improvvise attenzioni segnate dall'emotività e lunghi silenzi caratterizzati dalla rimozione. Quel che appare mancare è, invece, la concretezza delle azioni, la capacità di essere conseguenti. Spiace dirlo, ma talvolta sembrano venire meno anche quella serietà e quel rigore sempre dovuti e necessari di fronte a drammi e lacerazioni che toccano la vita di decine di migliaia di persone e di famiglie. La discontinuità delle attenzioni, da un lato, e un alto tasso di strumentalità e strumentalizzazione, dall'altro, allontanano l'efficacia delle risposte e dei servizi e la loro capacità e disponibilità di adattarsi alle persone, anziché pretendere il contrario. Vi sono, infatti, richieste di aiuto già mature e strutturate e altre che vanno accompagnate con passi attenti e adeguati alle forze di chi le esprime, perché non sono in grado di reggere ritmi diversi. Abbandonare queste ultime in ragione di metodologie e aspettative calibrate sulle prime, risulterebbe, prima di tutto, una forma di resa lesiva di un principio etico fondamentale: quello di aver cura della vita di tutti e di ciascuno. Ogni volta che, ragionando o legiferando attorno alle droghe, si arriva su questa soglia, o ci si ferma o si torna indietro, e la questione rimane lì, ripiegata su se stessa. Allora e purtroppo, anche l'anno documentato e scandito giorno per giorno in questo volume, come era stato per il precedente, si chiude senza che la grande ricchezza di riflessione, le proposte e le richieste delle migliaia di operatori per le tossicodipendenze riuniti nella Conferenza nazionale sulle droghe nel marzo 1997 siano state recepite e tradotte in nuove normative e in complessive strategie da parte di chi ne ha la responsabilità e il dovere: per primi il governo e il Parlamento. Tra le questioni del terzo tipo, quelle che sembrano essere state dolosamente fatte scomparire, troviamo il problema delle mafie, della corruzione e della criminalità economica. Talvolta, sembra che non esistano più, se non per l'eco di qualche processo o il breve richiamo d'attenzione quando viene coinvolto qualche personaggio di rilievo. I temi della sicurezza, in questi mesi, sembrano essersi spostati interamente sul controllo del territorio, sulle strategie di contrasto della criminalità cosiddetta di strada. Talvolta, ciò è avvenuto perché effettivamente vi sono ritardi o insufficienze nel doveroso ascolto della diffusa richiesta di legalità che viene da molte città; in altri casi e occasioni, vi è stato un corto circuito innescato, non sempre in buona fede, tra problemi che necessitano innanzitutto di politiche sociali (immigrazione e, appunto, tossicodipendenze) e la tutela della sicurezza di tutti i cittadini. Infine, tra le questioni che rischiano di essere drammaticamente semplificate, vi è proprio quella dell'immigrazione. Un fenomeno assai complesso, che necessita di strategie lungimiranti, prima ancora che accoglienti, pena il suo aggravarsi come fattore di conflitto. Se gli esodi dovuti alla fame si possono in qualche maniera intravedere, quelli provocati dalle guerre presentano caratteristiche ancor più sconvolgenti, poiché suscettibili di sviluppi imprevedibili. L'altro ieri il Libano, ieri la Bosnia, oggi il Kurdistan e il Kosovo. Sono movimenti di donne, uomini e bambini che non si possono fermare per decreto o per referendum: occorre che tutti che ce ne rendiamo bene conto. Anche qui, e forse qui più che altrove, è necessario conoscere per decidere, occorrono strategie, capacità di guardare avanti. Perché il vero pericolo, di fronte a realtà nuove, scomode o laceranti, è la loro ingovernabilità, che è poi l'esito ultimo ed evitabile dell'improvvisazione. Riuscire a governare i fenomeni del nostro tempo affinché non schiaccino mai l'uomo, i suoi diritti e la sua dignità, c'entra molto con l'informazione. Ma, soprattutto, c'entra molto con la speranza: un faro di cui abbiamo tutti bisogno per illuminare il cammino nel nuovo millennio ormai alle porte.
di Luigi Ciotti
|
